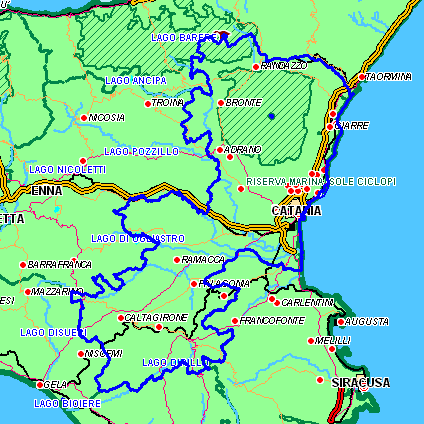Alfio Recupero



Vizzini
Vizzini si trova a quasi 600 metri s.l.m., in prossimità delle sorgenti del Fiume Dirillo o Acate e su tre colli rientranti nei Monti Iblei, esattamente il Colle Castello, il Colle Maddalena ed il Colle Calvario. A pochi chilometri, inoltre, si trova illago Dirillo, ottenuto dallo sbarramento dell’omonimo fiume: un’area turistica e sportiva di oltre 20 milioni di metri cubi.
È una delle più antiche città della Sicilia. Le prime notizie certe risalgono alla tarda età del bronzo, come testimoniano ireperti rinvenuti nella Contrada “Tre Canali”, oggi custoditi presso il Museo Paolo Orsi di Siracusa. Dopo i Greci e i Romani, fu dominata dai Bizantini e poi dagli Arabi. Vizzini è stata l’ambientazione privilegiata di molte novelle e romanzi del grande scrittore siciliano Giovanni Verga, che proveniva da una famiglia di origini vizzinesi.
Vizzini conserva ancora integra la costituzione originaria del suo centro storico, cosa che le conferisce un particolare fascino. Intorno alla centrale Piazza Umberto I si affacciano il Palazzo Verga ed il Palazzo Municipale, di fianco al quale si erge la Salita Marineo, una lunga scalinata decorata, sulle alzate, da maioliche a motivi geometrici e floreali, con al centro di ognuna un medaglione con scorci di palazzi vizzinesi. La Chiesa Madre, intitolata a San Gregorio, conserva della sua originaria costruzione un portale gotico normanno, sopravvissuto al terremoto del 1693. L’edificio si presenta con un incrocio di stili. L’interno è suddiviso in tre navate ed ha una struttura ottagonale ed archi a sesto acuto. Vi si possono ammirare due splendidi dipinti realizzati dall’artistaFilippo Paladino nei primi anni del 1600 e rappresentanti il primo il Martirio di San Lorenzo ed il secondo la Madonna della Mercede. Nelle vicinanze della Chiesa Madre si trova la Basilica di San Vito sotto il titolo di Spirito Santo. La chiesa si presenta in stile tardobarocco con reminiscenze rinascimentali ed offre la possibilità di ammirare un Crocifisso ligneo scolpito, una cappella decorata riccamente da stucchi di gusto neoclassico ed un reliquario. La Chiesa di S. Agata, edificata intorno al XIV secolo, fu ricostruita nel XVIII ed originariamente intitolata a San Pietro. Al suo interno possiamo ammirare una pala d’altare raffigurante il Martirio di S. Agata e la Cappella barocca, dedicata al Sacramento.
All’interno di un palazzo settecentesco del centro storico è possibile visitare il Museo “Immaginario Verghiano”. Cuore del museo è la Mostra permanente delle foto di Giovanni Verga, arricchita da una serie di cimeli, molti dei quali relativi alla strumentazione fotografica che lo scrittore utilizzava. Vi è poi una sezione dedicata alla raccolta di foto di set cinematografici dei film ispirati alle opere verghiane, mentre la sezione intitolata “Archivi della memoria” raccoglie un interessante materiale fotografico fatto di immagini dei luoghi e delle genti del mondo verghiano dagli anni ‘20 sino alla seconda metà del Novecento. In contrada Masera si trovano i resti di un complesso di case e opifici denominato“Cunziria” (conceria), reso famoso da Verga che vi ambientò “Cavalleria Rusticana”.
Il prodotto tipico per eccellenza della città di Vizzini è la ricotta fresca. Nel corso degli anni si è sviluppata una forte specializzazione nel settore dell’allevamento degli animali da latte e della produzione di formaggi di varia natura, da quelli freschi a quelli che richiedono una breve, media o lunga stagionatura.
Aci e Galatea, la leggenda d’amore scorre dall’Etna fino al mare.
Vi siete mai domandati perché tanti paesini in provincia di Catania iniziano tutti con lo stesso nome, Aci? Galeotta fu una bellissima storia d’amore tra un pastorello di nome Aci e una ninfa di nome Galatea.
Le leggende strettamente legate alla maestosa Etna sono tante e la sua bellezza ha ispirato poeti e narratori. Questa leggenda è tra le più belle storie d’amore della mitologia, una leggenda che Ovidio narra nel XIII libro delle Metamorfosi.
La leggenda narra di Polifemo, ciclope che abitava nel vulcano, perdutamente innamorato della giovane Galatea. La bellissima ninfa era una delle cinquanta ninfe del mare, le Nereidi, figlie delle divinità marine Doride e Nereo.
Aci era un bellissimo pastorello, figlio di Fauno, che pascolava le sue pecore vicino al mare, quando un giorno vide Galatea e se ne innamorò perdutamente; l’amore fu ovviamente ricambiato dalla ninfa. Aci e Galatea erano innamoratissimi e si rivelavano dunque inutili le avance di Polifemo verso la ninfa.
Una sera, al chiarore della luna, il ciclope vide i due innamorati in riva al mare baciarsi. Accecato dalla gelosia decise di vendicarsi. Non appena Galatea si tuffò in mare, Polifemo prese un grosso masso di lava e lo scagliò contro il povero pastorello schiacciandolo. Appena Galatea seppe della terribile notizia, accorse subito e pianse tutte le sue lacrime sopra il corpo martoriato di Aci. Giove e gli dèi ebbero pietà e trasformarono il sangue del pastorello in un piccolo fiume che nasce dall’Etna e sfocia nel tratto di spiaggia proprio dove i due amanti erano soliti incontrarsi.
Il piccolo fiume venne chiamato dagli antichi greci “Akis” e, in località Capo Molini (poco distante dal mare) c’è una piccola sorgiva chiamata “u sangu di Jaci”, dovuto al suo colore rossastro. Così il fiume ha dato il nome alle nove cittadine; Aci Castello, il cui nome deriva dall’omonimo castello di epoca normanna, costruito su un promontorio di roccia vulcanica a picco sul mare, oggi sede del museo civico. Aci Trezza, piccolo e grazioso borgo di pescatori dove dalle sue acque limpide emergono i faraglioni dei Ciclopi, souvenir delle ire di quest’ultimi e l’isola Lachea. Ma Aci Trezza è famosa soprattutto per il libro di Giovanni Verga, “I Malavoglia” ed è proprio qui che Luchino Visconti girò il suo film “La terra trema”, ispirandosi al libro dello scrittore siciliano.
Acireale, città ricca di palazzi e chiese barocche; centro di antiche tradizioni termali dove sorgono le “Terme di Acireale”. La città è famosissima per il suo carnevale denominato “Il più bel carnevale di Sicilia“, dove i carri allegorici e floreali sfilano per le strade principali. Nella villa comunale sono custodite delle bellissime statue raffiguranti Aci e Galatea nel momento più tragico della loro storia d’amore. Assolutamente da visitare.
Aci Catena: originariamente era l’antica Scarpi,ma nel 1826 prese il nome attuale per la venerazione nei confronti della Madonna della Catena. La piccola cittadina conserva un grazioso centro storico, con il suo palazzo municipale e gli antichi palazzi dell’800 e del’900. Aci San Filippo, frazione di Aci Catena, conserva una bellissima chiesa Madre affiancata da un campanile dal basamento di pietra lavica; è la cittadina più antica delle nove Aci.
Aci Platani, che dopo il terremoto del 1693 vide ricostruita la propria chiesa Madre, dove all’interno sono custoditi i dipinti di Alessandro Vasta e Giacinto Platania. Inoltre ha un museo dedicato alla cultura contadina dove ricostruisce una casa rurale etnea del XIX secolo. Aci Santa Lucia, frazione di Aci Catena: il nome deriva dall’antica chiesa di Santa Lucia dove è conservata una bellissima statua policroma della Santa siracusana.
Aci Bonaccorsi: antico borgo appartenente dal XIV secolo alla nobile famiglia dei principi di Campofiorito, dove ogni anno, nei primi giorni di agosto, si può assistere al Festival nazionale dei fuochi d’artificio. Ed infine, Aci Sant’Antonio. La facciata del Duomo della città domina la piazza principale, da dove si snoda il corso Vittorio Emanuele che si chiude con i resti del palazzo della famiglia dei principi Riggio.
La leggenda popolare narra inoltre che il corpo del povero pastorello sia stato smembrato in nove parti cadute poi dove sono nate le nove Aci. Così la fantasia dell’uomo ha voluto spiegare la presenza di questa sorgente di acqua dolce che scorre vicino al mare.
A noi piace credere che questa dolce, ma purtroppo tragica storia d’amore continui tutt’ora nell’azzurro mar Jonio, dove ad attendere il fiume Aci vi è la sua amata Galatea, dove ormai Polifemo non può far nulla.
Aci era figlio di Fauno e una ninfa nata in riva al Simeto:
delizia grande di suo padre e di sua madre,
ma ancor più grande per me; l’unico che a sé mi abbia legata.
bello, aveva appena compiuto sedici anni
e un’ombra di peluria gli ombreggiava le tenere guance.
Senza fine io spasimavo per lui, il Ciclope per me.
Clicca sulla foto
Comuni in provincia di
Catania
Provincia di Catania
L’Opera dei Pupi di stile catanese
L’Opera dei Pupi è un particolare tipo di teatro delle marionette che si affermò stabilmentenell’Italia meridionale e soprattutto in Sicilia tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima metà delNovecento. I pupi siciliani si distinguono dalle altre marionette essenzialmente per la loro peculiaremeccanica di manovra e per il repertorio, costituito quasi per intero da narrazioni cavallereschederivate in gran parte da romanzi e poemi del ciclo carolingio.Le marionette del Settecento venivano animate dall’alto per mezzo di una sottile astametallica collegata alla testa attraverso uno snodo e per mezzo di più fili, che consentivano imovimenti delle braccia e delle gambe. In Sicilia, nella prima metà dell’Ottocento, un genialeartefice di cui ignoriamo il nome escogitò gli efficaci accorgimenti tecnici che trasformarono lemarionette in pupi. Egli fece in modo che l’asta di metallo per il movimento della testa non fossepiù collegata ad essa tramite uno snodo, ma la attraversasse dall’interno e - cosa ben più importante- sostituì il sottile filo per l’animazione del braccio destro con la robusta asta di metallocaratteristica del pupo siciliano. Questi nuovi espedienti tecnici consentirono di imprimere allefigure animate movimenti più rapidi, diretti e decisi, e perciò particolarmente efficaci per “imitare”sulla scena duelli e combattimenti, che tanta parte avevano nelle storie cavalleresche. Queste, bennote da lungo tempo in Sicilia grazie al racconto dei cuntastorie nelle piazze, riscuotevano nei primidecenni dell’Ottocento un rinnovato successo, favorito dagli entusiasmi per il Medioevo risvegliatidal Romanticismo. Ogni ciclo cavalleresco venne così rappresentato all’Opera dei Pupi in moltepuntate, che si susseguivano di serata in serata, collegate attraverso un sapiente meccanismo diinterruzione dell’azione ereditato dal cuntu dei cuntastorie e finalizzato ad incatenare il pubblicoper farlo tornare l’indomani.I pupi, che già avevano acquisito il loro peculiare sistema di manovra, furono ben prestoarricchiti delle loro scintillanti armature di foggia vagamente rinascimentale. Nella seconda metàdell’Ottocento nei teatri di quartiere di tutta l’isola i paladini di Carlo Magno, percepiti dal loropubblico più come persone vere che come fantocci animati, incarnavano già frustrazioni, gioie esperanze del popolo siciliano. Come è stato messo debitamente in luce dalle riflessioni di AntoninoButtitta ed Antonio Pasqualino, da considerare ormai definitivamente acquisite alla storia deglistudi sull’Opra, essa, per il suo pubblico tradizionale, assolveva a due importantissime funzioni. Daun lato, offriva una griglia d’interpretazione del mondo, poiché i singoli personaggi delle vicendecavalleresche diventarono esempi cui riferirsi per classificare persone incontrate nella vita di ognigiorno. D’altro canto, incarnando ritualisticamente ogni sera l’aspirazione ad un ordine del mondopiù giusto ed offrendo sul piano del simbolico una risoluzione delle opposizioni sperimentate comeinconciliabili nella prassi quotidiana, l’Opera dei Pupi era “un riscatto mitico dalla propriacondizione di subalternità”.Esistono in Sicilia due differenti tradizioni, o “stili”, dell’Opera dei Pupi: quellapalermitana, affermatasi nella capitale e diffusa nella parte occidentale dell’isola, e quellacatanese, affermatasi nella città etnea e diffusa, a grandi linee, nella parte orientale dell’isola edanche in Calabria. Le cronache raccontano che l’iniziatore dell’Opra a Catania fu don GaetanoCrimi (1807 - 1877), il quale aprì il suo primo teatro nel 1835.Le due tradizioni differiscono per dimensioni e peso dei pupi, per alcuni aspetti dellameccanica e del sistema di manovra, ma soprattutto per una diversa concezione teatrale e dellospettacolo, che ha fatto sì che nel catanese si affermasse un repertorio cavalleresco ben più ampio diquello palermitano e per molti aspetti diverso.I pupi catanesi arrivano fino a un metro e trenta di altezza e possono raggiungere un peso diKg. 35, mentre i pupi palermitani raramente superano i cm. 80 di altezza ed i Kg. 5 di peso. I pupicatanesi hanno le gambe rigide, senza snodo al ginocchio, e, se sono guerrieri, tengono quasisempre la spada impugnata nella mano destra; invece, i pupi palermitani possono articolare leginocchia e sguainano e ripongono la spada nel fodero. Mentre i pupi palermitani vengonomanovrati da animatori posizionati dietro le quinte poste ai lati del palcoscenico, con i piedipoggiati sullo stesso piano di calpestio dei pupi, i pupi catanesi sono animati dall’alto di un ponteposto dietro i fondali (‘u scannappoggiu). I manianti, cioè gli animatori, reggono i pupi poggiando ipiedi su una spessa tavola di legno sospesa a circa un metro da terra (‘a faddacca). Il differentesistema di animazione dei pupi catanesi rispetto a quelli palermitani, conseguenza dell’altezza dellemarionette e del loro notevole peso, spiega anche il motivo dell’adozione del ginocchio rigido, chepuò essere datata, ma con molta approssimazione, agli anni Cinquanta - Sessanta dell’Ottocento:per alleggerire un poco la fatica del braccio dell’animatore e scaricare in qualche modo il peso deipupi, fu necessario renderne rigide le gambe. Il grande peso ed il sistema di manovra dei pupicatanesi fatto sì che a Catania il ruolo di maniante non coincidesse mai con la stessa persona che dàla voce ai pupi, il cosiddetto parlatore, il quale è quasi sempre anche il “regista” dello spettacolo.Mentre a Palermo l’ambiente dell’Opra era piuttosto chiuso, a Catania i pupari prendevanocostantemente a modello per le loro messinscene gli elaborati allestimenti scenotecnici del teatrolirico e le modalità di recitazione dei grandi attori ottocenteschi e del teatro verista. Questi continuiprocessi di imitazione scenografica dell’opera lirica e di osmosi col teatro degli attori viventiinfluenzarono profondamente la concezione spettacolare e teatrale dei pupari catanesi. Se a Palermol’Opra rimase uno spettacolo più elementare e stilizzato, a Catania la recitazione fu piùsentimentale e drammatica. I parlatori cercarono di emulare l’impostazione della voce ed il mododi recitare dei “grandi attori” alla Ernesto Rossi. In omaggio ad una vocazione al realismo, ipersonaggi femminili furono sempre parlati da parlatrici donne, mentre a Palermo l’unica vocemaschile del puparo li “doppiava” in falsetto. Tutto lo spettacolo venne consapevolmente costruitoed orientato dai pupari verso un crescente pathos tragico, che rimane a mio avviso la nota piùcaratterizzante dell’Opra catanese. Essa, attingendo a piene mani, consapevolmente oinconsapevolmente, a tutte le esperienze teatrali succedutesi in Sicilia dal teatro barocco in poi,raccoglieva sulle tavole dei suoi umili palcoscenici tutta la sapienza tragica dell’orizzonte europeo.Questa vocazione al tragico determinò nel repertorio dell’Opra catanese l’affermarsi, accantoalle vicende dell’antico ciclo carolingio, di storie cavalleresche inventate alla fine dell’Ottocento oai primi del Novecento, che accoglievano, insieme agli elementi tipici del genere, altre suggestioniculturali, contemporanee e non. Studiando gli intrecci della Storia Greca rappresentata nei teatricatanesi, dell’Erminio della Stella d’Oro, del Guido di Santa Croce, dell’Uzeta catanese, delFarismane e Siface, del Tramoro di Medina, del Guelfo di Negroponte, del Tullio di Russia, mi èstato possibile individuare “ingredienti” derivanti, oltre che dalla narrativa cavalleresca, dalleseguenti fonti: la letteratura greca e latina; il teatro shakespeariano, conosciuto direttamente oattraverso la mediazione del melodramma; i romanzi storici italiani dell’Ottocento romantico erisorgimentale (Ettore Fieramosca e Niccolò de’ Lapi di Massimo d’Azeglio, Marco Visconti diTommaso Grossi, L’assedio di Firenze di Francesco Domenico Guerrazzi); il romanzo popolared’appendice nel suo primo periodo romantico – eroico, per intenderci quello alla Sue ed allaDumas; le storie più famose di santi martiri, piene di supplizi e torture, conosciute attraverso latradizione orale e/o l’iconografia religiosa. Tenendo presenti queste fonti, le storie catanesiagglomerano e moltiplicano nei loro intrecci tutto l’armamentario di topoi tipici del feuilleton e delromanzo gotico suo antenato: figli perduti o abbandonati e inevitabili agnizioni, talvolta tragiche;vendette giustiziere; tormentate passioni amorose; “fratelli nemici”; parricidi ed incesti consumati oappena scampati; re sadici che in oscure segrete godono di torturare fanciulle e suore perché questenon vogliono piegarsi alle loro voglie. Tutti questi ingredienti venivano sapientemente manipolatiogni sera dalla grande capacità attoriale e tragica dei pupari catanesi, che, attraverso la lororecitazione e messinscena, trasformavano le trame di romanzi d’appendice “medievalizzati” in unagrande e reiterata lezione sulla tragicità dell’esistenza umana.Oggi la vita della tradizione spettacolare ed artigiana dell’Opera dei Pupi catanese è affidataalla Marionettistica dei fratelli Napoli di Catania, una compagnia attiva dagli inizi del Novecento edalla quale chi scrive si onora di appartenere. Diretta da Fiorenzo Napoli, che è anche uno degliultimi autentici depositari dell’arte di costruire i pupi a Catania, questa compagnia ha saputoadattare l’Opra catanese alle esigenze di un pubblico contemporaneo, pur mantenendosi fedele aicodici e alle regole di messinscena della tradizione. E ciò, nei giorni passati e presenti, ha costituitoun impegno notevole.Negli anni Sessanta e Settanta del Novecento, il pubblico tradizionale dell’Opra, quelloaffezionato che amava i pupi come persone reali e andava a seguire le puntate serali, cominciò adisertare i teatri. Il boom economico e consumistico aveva prodotto un pericoloso fenomenoculturale: i ceti popolari, che ormai avevano libero accesso ai beni di consumo, identificavano glielementi tradizionali della loro cultura come simboli tout court della precedente miseria. Di questoprocesso culturale fecero le spese pupi e pupari: i primi non erano più eroi simbolo in cuiidentificarsi; i secondi dovevano rinunciare al loro status di “sacerdoti” di un rito di riconferma dicultura che si celebrava ogni sera. Non c’era più il pubblico popolare e serale, che oltretutto eraanche un pubblico “iniziato”, in quanto conosceva già in anticipo gli intrecci delle storierappresentate. Ai pupari si impose una stringente alternativa: o vendere i pupi e cambiare mestiere ocongegnare spettacoli che potessero fare breccia in un pubblico non popolare e borghese: personenon “iniziate”, che poco sapevano degli intrecci delle storie cavalleresche e che comunque nonsarebbero tornate a teatro l’indomani. Non tutti i pupari accolsero la sfida e molti svendettero pupi eattrezzature. Furono anni difficili, caratterizzati da un travaglio faticoso, che spesso all’interno dellecompagnie di lunga tradizione causò accesi dibattiti e qualche conflitto fra gli esponenti dellevecchie e delle nuove generazioni. Il lavoro che le pochissime compagnie di pupari rimaste inattività fecero in quegli anni e nei successivi anni Ottanta e Novanta è stato attentamentedocumentato e studiato da Antonio Pasqualino, il quale fece un primo punto della situazione in unsuo scritto del 1981, successivamente aggiornato nel 1992.Le difficoltà del lavoro di adattamento dello spettacolo dei pupi al pubblico contemporaneoerano principalmente di due ordini. Bisognava innanzitutto costruire spettacoli che presentassero inuna sola sera una vicenda già conclusa, rinunciando alla fruizione ciclica tradizionale, o comunqueconservandola solo per rare e particolari occasioni. Poi bisognava “calibrare” i codici tradizionalidella messinscena col gusto di un pubblico diverso da quello popolare: un pubblico che per di più,molto spesso, considerava l’Opera dei Pupi come una forma di teatro divertente per il linguaggiosgrammaticato del puparo o le macchinosità meccaniche nei movimenti delle figure animate. Perpoter procedere a questo lavoro, occorrevano conoscenza approfondita degli intrecci delle storie epiena padronanza dei sette codici di messinscena dell’Opera dei Pupi identificati da Pasqualino eVibaek 1977 e 1984: il codice linguistico, i codici delle qualità della voce, il codice dei rumori e deisuoni vocali inarticolati, il codice della musica, il codice cinesico (o dei movimenti e dei gesti), icodici figurativi dei luoghi e dei personaggi. Per poter “smontare” i codici e adattarli alle nuoveesigenze di pubblico senza rinnegare la tradizione, è necessario che questi codici siano stati appresiattraverso anni di lungo e paziente tirocinio alla scuola di rinomati maestri. Di fatto, fu questa lapossibilità che consentì allora di vincere la sfida coi tempi a pochissime famiglie di pupari che sitramandavano il mestiere da più generazioni: è d’obbligo ricordare qui, oltre ai fratelli Napoli diCatania, i Figli d’Arte Cuticchio di Palermo.A Catania, un’altra difficoltà si aggiungeva a queste: diventava sempre meno facile reperire spaziche consentissero ai pupi di agire, non potendosi sempre trovare sale atte a poter montare il loropalcoscenico e boccascena. Per risolvere il problema e portare i pupi catanesi in ambienti ristretticome le palestre e i teatrini scolastici, le sale parrocchiali, le sale conferenze di circoli e sodaliziculturali, Natale Napoli escogitò nel 1973 l’idea dei “pupi piccoli” di cm. 80, che, ridotti nelledimensioni, consentirono alla tradizione catanese di confrontarsi con un numero ben maggiore dipubblici di quanto avrebbero permesso i “pupi grandi”. I “pupi piccoli”, mantenendo assolutamenteintatti codici, regole e tecniche della messinscena tradizionale, assicurarono la possibilità diaffezionare all’Opra catanese un nuovo pubblico, composto da giovani in età scolare e studentiuniversitari, professionisti, borghesi, e uomini di cultura.Nel 1978, i fratelli Napoli ricevettero dai Reali d’Olanda il prestigioso PraemiumErasmianum, che “corona persone ed istituzioni che per la loro attività hanno arricchito la culturaeuropea”. La motivazione ufficiale con cui fu assegnato il premio riconosceva ai Napoli il loroimpegno nell’adattare le antiche favole cavalleresche della tradizione siciliana alle esigenze ed algusto del pubblico contemporaneo: “Quia secundum priscum morem Siciliae antiquas fabulaspopulares incorrupte nec tamen sine cura atque respectu spectatorum huius temporis exprimunt.”I figli di Natale Napoli hanno appreso dal padre e dallo zio Pippo i codici e le regole dellatradizione. Fiorenzo Napoli è riuscito a trasferirli ai suoi tre figli Davide, Dario e Marco. Deltravaglio culturale vissuto dalla Marionettistica e dall’Opra catanese, i fratelli Napoli hanno cercatodi dare conto in un recente spettacolo intitolato L’oro dei Napoli, con la regia di Elio Gimbo.Attraverso la scrittura drammaturgica di Salvatore Zinna, nata da una lunga serie di conversazionicon tutti gli elementi della compagnia, e attraverso le scene dei pupi che con Fiorenzo Napoliabbiamo recuperato dalle storie tradizionali, si cercano le ragioni della resistenza dell’Opracatanese agli assalti dell’era del consumismo e del suo persistere fino all’anno del Signore 2007. Ele si individuano proprio nella trasmissione di regole, codici e competenze da una generazioneall’altra, condizione primaria per assicurare linfa vitale alla tradizione.Alessandro NapoliRiferimenti bibliograficiButtitta Antonino.1977 “Prefazione”, in Pasqualino Antonio, L’opera dei pupi, Sellerio editore, Palermo 1977, pp. 11-13.1981 “L’opera dei pupi come rito”, in AA. VV. , I pupi e il teatro, Quaderni di teatro. Rivista trimestraledel Teatro Regionale Toscano, Anno IV, n. 13, agosto 1981, Vallecchi editore,Firenze 1981, pp. 30-34.1989 “Il rito dell’opra”, in Buttitta Antonino - Miceli Silvana, Percorsi simbolici, a cura di GabriellaD’Agostino, S. F. Flaccovio, Editore, Palermo 1989, pp. 149-154.Napoli Alessandro.2002 Il racconto e i colori<< Storie>> e << cartelli>> dell’Opera dei Pupi catanese, Sellerio editore,Palermo.